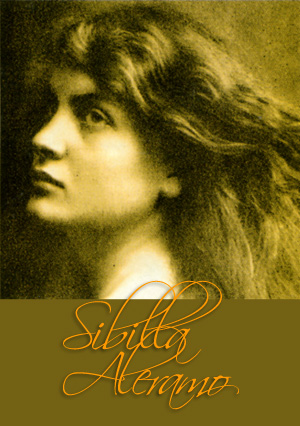|
Numero 18
Feed RSS
Archivio
|
stampa questa pagina [versione printer friendly]
Storia di una donna
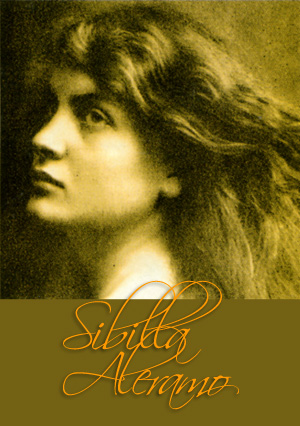
La vita di Sibilla Aleramo a un certo punto incrocia un bivio terribile: la scelta tra il figlio e la libertà da un matrimonio infelice che la spinge a tentare il suicidio. Lei sceglie, e se ne va. Più tardi, attraverso la scrittura ricompatterà i frammenti dolorosi di quell’esperienza.
di Francesca Pacini
C’è come uno scarto, nella vita di Sibilla Aleramo, tra un’infanzia serena, segnata dall’adorazione per il padre, e un’adolescenza inquieta, livida, in cui si disegnano quelle ombre che minacceranno, perseguitandola, tutta la sua vita da adulta. Fino alla scelta di porre fine a un matrimonio infelice cedendo, in cambio della libertà, il bene più prezioso, irripetibile: suo figlio.
La scrittura della Aleramo è folgorante. Penetra, si insinua come una goccia d’acqua nell’anima del lettore fino a corroderla, a corromperla, trascinandola nelle oscure grotte interiori in cui la donna combatte i sui demoni personali. Alla fine sarà la luminosa consapevolezza di una missione a salvarla, sollevandola attraverso le ombre con il battito d’ala di un’intuizione feroce nella sua lucidità: non si può rinunciare a sé stessi. Non si può barattare l’anima, neppure in cambio del tepore – che nulla in cambio chiede - di un figlio.
Sibilla Aleramo non è solo la donna che amò Dino Campana, o l’ardente intellettuale antifascista che si batté per i diritti sociali, sempre attenta alla questione femminile. Sibilla Aleramo è anche la donna che sta dentro e dietro la scrittrice, che ne guida e ne anticipa i passi. È questa donna a forgiare la scrittrice, temprata a ferro e fuoco attraverso la lunga, dolorosa vicenda matrimoniale che la porta perfino a tentare il suicidio. È la donna che comprende, con uno straordinario scatto moderno rispetto al tempo in cui vive, che le figure “autorizzate” di moglie e madre non possono essere, non sempre almeno, il riscatto di una vita incompiuta.
“La buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana. E come può diventare una donna, se i parenti la danno, ignara, debole, incompleta, a un uomo che non la riceve come sua eguale; ne usa come d’un oggetto di proprietà; le dà dei figli coi quali l’abbandona sola, mentr’egli compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi nell’infanzia?”
Già, quante donne oggi, menomate da matrimoni infelici, continuano a baloccarsi nell’infanzia immaginandosi madri per perpetuare invece, a loro stessa insaputa, l’essere perennemente quelle figlie bisognose di qualunque attenzione, affetto, amore. Figlie costrette a negarsi la libertà di esistere se non in funzione di quella moglie, di quella madre infelice che, come nota Sibilla, non potrà mai consegnarsi realmente a suo figlio se non nella misura del simulacro ch’è diventata? Ricordando sua madre, Sibilla attinge alla memoria con straordinario nitore analitico: “Per diciotto anni l’infelice aveva vissuto nella casa coniugale. Come moglie, le poche gioie si erano mutate in infinite pene: come madre non aveva mai goduto la riconoscenza delle sue creature. Il suo cuore non aveva mai trovato la via dell’effusione. Era passata nella vita incompresa da tutti: fanciulla, la sua famiglia la considerava romantica, esaltata e allo stesso tempo inetta, benché fosse la più intelligente e la più seria della numerosa figliolanza. Aveva rotto senza rimpianto quasi ogni rapporto con i parenti, antipatici allo sposo (…). Amare sacrificarsi e soccombere! Questo il destino suo e forse di tutte le donne?” Sibilla assiste al lento disfacimento della madre, la vede estinguere il pallido calore che la anima fino a capitolare, infelice e malata. Quello di Sibilla invece non è un fuoco fatuo, in lei arde una fiamma capace di appiccare incendi. Tenta di annullarla, di depositarla in fondo all’anima ma questo fervore interno persiste, brucia nell’essere, lo spinge a espandersi travolgendo ogni argine.
Purtroppo, l’ultimo argine è proprio suo figlio, quello spensierato bimbetto che irrora la sua vita facendole scordare, anche se per un breve istante, l’oppressione a cui la condanna un marito rozzo, mediocre, che con la forza l’ha presa la prima volta e con la forza la imprigiona in quelle nozze infelici. A volte la violenza si fa sinuosa, sorda ai clamori di azioni gridate. E lui preme sulla coscienza materna per legare a sé Sibilla, mantenendola in un paesino volgare, lontano dall’ebbrezza di quella Roma che in un breve, intenso periodo, era stata per lei luce e ristoro. “Città di esaltamento e di pace!” così la descrive nelle pagine in cui racconta il suo soggiorno nella capitale. Perché Roma abbevera il suo spirito assetato, ed è nelle fatiche redazionali della piccola società editrice per cui collabora che trova finalmente la traccia del suo destino. Il canovaccio si compone ancora lentamente, ma Sibilla si muove sicura ritrovando il mondo dei libri, delle idee, della scrittura che aveva scortato la sua infanzia e la sua adolescenza. Bisogna infatti ricordare che se la percezione dell’infanzia in lei è felice, questo accade per il miracolo di un amore edipico nei confronti del padre che la preserva dal dramma di un rapporto coniugale che in realtà, fin da quando è bambina, non funziona, riversandosi anche su di lei e sulle sorelle. Un amore irrobustito dalle feconde conversazioni col padre e fertilizzato da una precoce attitudine alla lettura. “Il babbo dirigeva i miei studi e le mie letture, senza esigere da me molti sforzi”.
Solo più tardi Sibilla subirà l’impatto con l’infelicità porosa che grava sulle mura domestiche, e capirà come il padre non è soltanto il “luminoso esemplare” – come lo chiama – dei suoi giorni di bimba ma è anche l’uomo aspro che tradisce la moglie, l’uomo incapace di provare compassione (e non solo verso di lei ma verso il mondo intero).
Dunque Sibilla, inconsciamente come sempre accade, ripercorre le orme del destino materno ritrovandosi in un matrimonio infelice con un uomo che non la comprende. Non la tradisce con altre donne come aveva fatto il padre, è vero, ma attenta alla sua interezza in modo ancora più duro: ne impedisce il fiorire dell’anima usando un amore malsano, ossessivo, incapace di dare ma solo di esigere.
Solo l’arrivo del figlio dona nuova linfa al suo cuore stanco. “Quando, alla luce incerta di un’alba piovosa d’aprile, posi per la prima volta le labbra sulla testina di mio figlio, mi parve che la vita per la prima volta assumesse a’miei occhi un aspetto celestiale, che la bontà entrasse in me, che io divenissi un atomo dell’Infinito, un atomo felice, incapace di pensare e di parlare, sciolto dal passato e dall’avvenire, abbandonato nel Mistero radioso”.
Se in qualcuno dovessero sorgere dubbi sull’istinto materno che allarga, da quel momento in poi la sua vita, queste parole sole basterebbero a fugarlo. È vero, Sibilla lascerà suo figlio, ma non perché non lo ama. Al contrario. Lo abbandona perché, se restasse, non potrebbe donargli sé stessa. E se non dona sé stessa, non dona nulla. Solo un abbraccio impoverito, spossessato di una coscienza integra, pacificata con la sua essenza profonda. Lei intuisce ciò che gli psicanalisti sanno bene da sempre: malgrado ogni tentativo operato dalla psiche, “arriva” al figlio ciò che una madre realmente è, e sente. E se razionalmente una donna si racconta di essere soddisfatta, serena, è il suo l’inconscio a imprimere un segno nel figlio, marchiandolo a fuoco con l’angoscia e la sofferenza che lui, come una piccola spugna assorbente, riceve senza alcun filtro. Non stiamo giudicando, qui, se una madre debba restare o no accanto al figlio nonostante un matrimonio disastroso.
Ognuno, dentro di sé, sa qual è la strada giusta. È una scelta privata, individuale, da compiersi nell’intimità della coscienza. Stiamo però dicendo che Sibilla intuisce che se si sacrifica per il figlio restando in famiglia, forse quel sacrificio sarà vano. Sarà la sua ombra a guidarlo, non lei. “Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell’immolazione materna? Di madre in figlia, da secoli, si tramanda il servaggio. È una mostruosa catena. Tutte abbiamo, a un certo punto della vita, la coscienza di quel che fece pel nostro bene chi ci generò; e con la coscienza il rimorso di non aver compensato adeguatamente l’olocausto della persona diletta. Allora riversiamo sui nostri figli quanto non demmo alle madri, rinnegando noi stesse e offrendo un nuovo esempio di mortificazione, di annientamento. Se una buona volta la fatale catena si spezzasse, e se una madre non sopprimesse in sé la donna, e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità? Allora si incomincerebbe a comprendere che il dovere dei genitori s’inizia ben prima della nascita dei figli, e che la loro responsabilità va sentita innanzi, appunto allora che più la vita egoistica urge imperiosa, seduttrice. (…) Per quello che siamo, per la volontà di tramandare più nobile e più bella in essi la vita, devono esserci grati i figli, non perché, dopo averli ciecamente suscitati dal nulla, rinunziamo all’essere noi stessi…”
Non ci riesce, Sibilla, a rinunciare a sé stessa. Ci prova, ci prova invano. Alla fine deve capitolare. Formidabile egoista oppure coraggiosa eroina? Ripetiamo, non ci interessa il giudizio né tantomeno formulare una critica universale sull’atteggiamento da tenere in questi casi…
Ci interessa scrutare, nelle sue pagine, il percorso di un’anima dibattuta fra la libertà che la chiama e il vincolo dell’amore.
La sostiene una fede interiore, silenziosa. Molto diversa da quella religione da cui il padre le aveva insegnato a diffidare. Ma è fede. A volte in un laico, anche se può sembrare un paradosso,il vento dello spirito transita in modo ugualmente sottile, e vibrante, che in un “credente”. Nelle pagine della Aleramo si coglie spesso una leggerissima – e penetrante – confidenza con il senso finale dell’universo, un afflato con il cosmo che la circonda. Come quando descrive la consapevolezza dell’appartenenza alla Terra, scoprendosi figlia e testimone. Parlando della natura, dice: “Ne emanava un fervore occulto che conoscono solo i grandi credenti e i grandi innamorati: coloro che adorano la Vita fuor di Sé stessi. Io scomparivo, con la mia miseria; davanti ai miei occhi non era più che la bellezza di quell’umano sforzo ergentesi nella vastità del mondo. Spettacolo che l’anima gelosamente accoglieva e serbava. Non era la gran rivelazione: era il lavorìo sotterraneo dei germi che già sentono il calore del sole vicino e ne temono e ne desiderano il pieno splendore.”
Accade anche a lei di vivere, come i germi di cui parla, il “lavorìo sotterraneo” in cui man mano la coscienza si fa vigile, pronta a mollare ogni fardello. Impossibile contrastare un’anima traboccante di dolore e di amore come la sua, un’anima sempre in cerca. E se il senso della sua esistenza non lo troverà nelle braccia cristiane, come accade a tanti credenti, questo non le toglierà il gusto del mistero divino: “Volgono le epoche, tramontano i sogni e le certezze, si trasformano le nostre brame; ma immutato resta il potere d’amore e di dolore nella creatura terrena, immutata la facoltà di esaltarsi sino a intendere voci fraterne nello spazio in apparenza deserto”.
Queste voci fraterne non saranno per Sibilla quelle dei fratelli raccolti in una chiesa, ma le voci dei poveri, dei diseredati. Quelle figure che non riesce a fuggire sono le stesse che incontra quando abbandona le vie centrali di Roma e si imbatte nelle case sporche, piene di lamenti e di sofferenze, che perimetrano con la loro ombra sinistra il raggiante centro della città, con le sue piazze assolate e le case con le finestre ingombre di fiori.
A un certo punto capisce anche che è incontrando la sofferenza degli altri che riesce a domare anche la sua, e si sente trascinata verso quelle questioni civili, sociali, di cui ha sempre letto con interesse.
Il tema femminile rimarrà per lei sempre centrale, però. “Quasi inavvertitamente il mio pensiero s’era giorno per giorno indugiato un istante di più su questa parola: emancipazione che ricordavo d’aver sentito pronunciare nell’infanzia, una o due volte, da mio padre seriamente, e poi sempre con derisione da ogni classe d’uomini e di donne. Indi avevo paragonato a quelle ribelli la gran folla delle inconsapevoli, delle inerti, delle rassegnate, il tipo di donna plasmato nei secoli per la soggezione e di cui io, le mie sorelle, mia madre, tutte le creature femminili da me conosciute, eravamo degli esemplari. E come un religioso sgomento m’aveva invaso. Io avevo sentito di toccare la soglia della mia verità, sentito ch’ero per svelare a me stessa il segreto del mio lungo, tragico affanno…”
La sua verità, la chiama. Perché giustamente ognuno ha una sua verità, un qualcosa di estremamente personale da conoscere e ri-conoscere dentro di sé.
Questo qualcosa pulsa, si agita, matura nello spazio concesso da una solitudine cercata, voluta, interrotta per lei solo dalle ore passate con il figlio. Al ritorno dal periodo romano in cui Sibilla incontra la sua vocazione letteraria e sociale, continueranno le percosse, le intimidazioni, le minacce da parte del marito, reso ancora più violento dalla fierezza di lei, da quel fuoco che nessuno può spegnere. L’incendio stavolta divampa sul serio. C’è un olocausto però, e una vittima da sacrificare: il figlio. Ma non può, non vuole consegnargli ciò che lei stessa ha ricevuto da sua madre: l’infelicità, lo sdoppiamento di un’anima scissa tra il richiamo a sé stessa e il voto materno. E decide di andarsene.
È questo il prezzo aspro che deve pagare. Sono pagine terribili quelle che descrivono l’ultima veglia, le incertezze e i ripensamenti, lo smarrimento davanti al faccino addormentato di lui. Vorrebbe portarlo via, rapirlo, ma non può. La legge le è contro. All’alba si strappa via dal lettino su cui dorme il bambino e se ne va, con le schegge del cuore ormai esploso che le schizzano via. Nella speranza di non perderlo, però. Nell’attesa che il bambino cresca, e capisca. In fondo è lui il cibo delle sue parole. “O forse io non sarò più… Non potrò più raccontargli la mia vita, la storia della mia anima…e dirgli che l’ho atteso per tanto tempo! Ed è per questo che scrissi. Le mie parole lo raggiungeranno”. L’ultima, tenace speranza.
La vita di Sibilla Aleramo a un certo punto incrocia un bivio terribile: la scelta tra il figlio e la libertà da un matrimonio infelice che la spinge a tentare il suicidio. Lei sceglie, e se ne va. Più tardi, attraverso la scrittura ricompatterà i frammenti dolorosi di quell’esperienza.
di Francesca Pacini
C’è come uno scarto, nella vita di Sibilla Aleramo, tra un’infanzia serena, segnata dall’adorazione per il padre, e un’adolescenza inquieta, livida, in cui si disegnano quelle ombre che minacceranno, perseguitandola, tutta la sua vita da adulta. Fino alla scelta di porre fine a un matrimonio infelice cedendo, in cambio della libertà, il bene più prezioso, irripetibile: suo figlio.
La scrittura della Aleramo è folgorante. Penetra, si insinua come una goccia d’acqua nell’anima del lettore fino a corroderla, a corromperla, trascinandola nelle oscure grotte interiori in cui la donna combatte i sui demoni personali. Alla fine sarà la luminosa consapevolezza di una missione a salvarla, sollevandola attraverso le ombre con il battito d’ala di un’intuizione feroce nella sua lucidità: non si può rinunciare a sé stessi. Non si può barattare l’anima, neppure in cambio del tepore – che nulla in cambio chiede - di un figlio.
Sibilla Aleramo non è solo la donna che amò Dino Campana, o l’ardente intellettuale antifascista che si batté per i diritti sociali, sempre attenta alla questione femminile. Sibilla Aleramo è anche la donna che sta dentro e dietro la scrittrice, che ne guida e ne anticipa i passi. È questa donna a forgiare la scrittrice, temprata a ferro e fuoco attraverso la lunga, dolorosa vicenda matrimoniale che la porta perfino a tentare il suicidio. È la donna che comprende, con uno straordinario scatto moderno rispetto al tempo in cui vive, che le figure “autorizzate” di moglie e madre non possono essere, non sempre almeno, il riscatto di una vita incompiuta.
“La buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana. E come può diventare una donna, se i parenti la danno, ignara, debole, incompleta, a un uomo che non la riceve come sua eguale; ne usa come d’un oggetto di proprietà; le dà dei figli coi quali l’abbandona sola, mentr’egli compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi nell’infanzia?”
Già, quante donne oggi, menomate da matrimoni infelici, continuano a baloccarsi nell’infanzia immaginandosi madri per perpetuare invece, a loro stessa insaputa, l’essere perennemente quelle figlie bisognose di qualunque attenzione, affetto, amore. Figlie costrette a negarsi la libertà di esistere se non in funzione di quella moglie, di quella madre infelice che, come nota Sibilla, non potrà mai consegnarsi realmente a suo figlio se non nella misura del simulacro ch’è diventata? Ricordando sua madre, Sibilla attinge alla memoria con straordinario nitore analitico: “Per diciotto anni l’infelice aveva vissuto nella casa coniugale. Come moglie, le poche gioie si erano mutate in infinite pene: come madre non aveva mai goduto la riconoscenza delle sue creature. Il suo cuore non aveva mai trovato la via dell’effusione. Era passata nella vita incompresa da tutti: fanciulla, la sua famiglia la considerava romantica, esaltata e allo stesso tempo inetta, benché fosse la più intelligente e la più seria della numerosa figliolanza. Aveva rotto senza rimpianto quasi ogni rapporto con i parenti, antipatici allo sposo (…). Amare sacrificarsi e soccombere! Questo il destino suo e forse di tutte le donne?” Sibilla assiste al lento disfacimento della madre, la vede estinguere il pallido calore che la anima fino a capitolare, infelice e malata. Quello di Sibilla invece non è un fuoco fatuo, in lei arde una fiamma capace di appiccare incendi. Tenta di annullarla, di depositarla in fondo all’anima ma questo fervore interno persiste, brucia nell’essere, lo spinge a espandersi travolgendo ogni argine.
Purtroppo, l’ultimo argine è proprio suo figlio, quello spensierato bimbetto che irrora la sua vita facendole scordare, anche se per un breve istante, l’oppressione a cui la condanna un marito rozzo, mediocre, che con la forza l’ha presa la prima volta e con la forza la imprigiona in quelle nozze infelici. A volte la violenza si fa sinuosa, sorda ai clamori di azioni gridate. E lui preme sulla coscienza materna per legare a sé Sibilla, mantenendola in un paesino volgare, lontano dall’ebbrezza di quella Roma che in un breve, intenso periodo, era stata per lei luce e ristoro. “Città di esaltamento e di pace!” così la descrive nelle pagine in cui racconta il suo soggiorno nella capitale. Perché Roma abbevera il suo spirito assetato, ed è nelle fatiche redazionali della piccola società editrice per cui collabora che trova finalmente la traccia del suo destino. Il canovaccio si compone ancora lentamente, ma Sibilla si muove sicura ritrovando il mondo dei libri, delle idee, della scrittura che aveva scortato la sua infanzia e la sua adolescenza. Bisogna infatti ricordare che se la percezione dell’infanzia in lei è felice, questo accade per il miracolo di un amore edipico nei confronti del padre che la preserva dal dramma di un rapporto coniugale che in realtà, fin da quando è bambina, non funziona, riversandosi anche su di lei e sulle sorelle. Un amore irrobustito dalle feconde conversazioni col padre e fertilizzato da una precoce attitudine alla lettura. “Il babbo dirigeva i miei studi e le mie letture, senza esigere da me molti sforzi”.
Solo più tardi Sibilla subirà l’impatto con l’infelicità porosa che grava sulle mura domestiche, e capirà come il padre non è soltanto il “luminoso esemplare” – come lo chiama – dei suoi giorni di bimba ma è anche l’uomo aspro che tradisce la moglie, l’uomo incapace di provare compassione (e non solo verso di lei ma verso il mondo intero).
Dunque Sibilla, inconsciamente come sempre accade, ripercorre le orme del destino materno ritrovandosi in un matrimonio infelice con un uomo che non la comprende. Non la tradisce con altre donne come aveva fatto il padre, è vero, ma attenta alla sua interezza in modo ancora più duro: ne impedisce il fiorire dell’anima usando un amore malsano, ossessivo, incapace di dare ma solo di esigere.
Solo l’arrivo del figlio dona nuova linfa al suo cuore stanco. “Quando, alla luce incerta di un’alba piovosa d’aprile, posi per la prima volta le labbra sulla testina di mio figlio, mi parve che la vita per la prima volta assumesse a’miei occhi un aspetto celestiale, che la bontà entrasse in me, che io divenissi un atomo dell’Infinito, un atomo felice, incapace di pensare e di parlare, sciolto dal passato e dall’avvenire, abbandonato nel Mistero radioso”.
Se in qualcuno dovessero sorgere dubbi sull’istinto materno che allarga, da quel momento in poi la sua vita, queste parole sole basterebbero a fugarlo. È vero, Sibilla lascerà suo figlio, ma non perché non lo ama. Al contrario. Lo abbandona perché, se restasse, non potrebbe donargli sé stessa. E se non dona sé stessa, non dona nulla. Solo un abbraccio impoverito, spossessato di una coscienza integra, pacificata con la sua essenza profonda. Lei intuisce ciò che gli psicanalisti sanno bene da sempre: malgrado ogni tentativo operato dalla psiche, “arriva” al figlio ciò che una madre realmente è, e sente. E se razionalmente una donna si racconta di essere soddisfatta, serena, è il suo l’inconscio a imprimere un segno nel figlio, marchiandolo a fuoco con l’angoscia e la sofferenza che lui, come una piccola spugna assorbente, riceve senza alcun filtro. Non stiamo giudicando, qui, se una madre debba restare o no accanto al figlio nonostante un matrimonio disastroso.
Ognuno, dentro di sé, sa qual è la strada giusta. È una scelta privata, individuale, da compiersi nell’intimità della coscienza. Stiamo però dicendo che Sibilla intuisce che se si sacrifica per il figlio restando in famiglia, forse quel sacrificio sarà vano. Sarà la sua ombra a guidarlo, non lei. “Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell’immolazione materna? Di madre in figlia, da secoli, si tramanda il servaggio. È una mostruosa catena. Tutte abbiamo, a un certo punto della vita, la coscienza di quel che fece pel nostro bene chi ci generò; e con la coscienza il rimorso di non aver compensato adeguatamente l’olocausto della persona diletta. Allora riversiamo sui nostri figli quanto non demmo alle madri, rinnegando noi stesse e offrendo un nuovo esempio di mortificazione, di annientamento. Se una buona volta la fatale catena si spezzasse, e se una madre non sopprimesse in sé la donna, e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità? Allora si incomincerebbe a comprendere che il dovere dei genitori s’inizia ben prima della nascita dei figli, e che la loro responsabilità va sentita innanzi, appunto allora che più la vita egoistica urge imperiosa, seduttrice. (…) Per quello che siamo, per la volontà di tramandare più nobile e più bella in essi la vita, devono esserci grati i figli, non perché, dopo averli ciecamente suscitati dal nulla, rinunziamo all’essere noi stessi…”
Non ci riesce, Sibilla, a rinunciare a sé stessa. Ci prova, ci prova invano. Alla fine deve capitolare. Formidabile egoista oppure coraggiosa eroina? Ripetiamo, non ci interessa il giudizio né tantomeno formulare una critica universale sull’atteggiamento da tenere in questi casi…
Ci interessa scrutare, nelle sue pagine, il percorso di un’anima dibattuta fra la libertà che la chiama e il vincolo dell’amore.
La sostiene una fede interiore, silenziosa. Molto diversa da quella religione da cui il padre le aveva insegnato a diffidare. Ma è fede. A volte in un laico, anche se può sembrare un paradosso,il vento dello spirito transita in modo ugualmente sottile, e vibrante, che in un “credente”. Nelle pagine della Aleramo si coglie spesso una leggerissima – e penetrante – confidenza con il senso finale dell’universo, un afflato con il cosmo che la circonda. Come quando descrive la consapevolezza dell’appartenenza alla Terra, scoprendosi figlia e testimone. Parlando della natura, dice: “Ne emanava un fervore occulto che conoscono solo i grandi credenti e i grandi innamorati: coloro che adorano la Vita fuor di Sé stessi. Io scomparivo, con la mia miseria; davanti ai miei occhi non era più che la bellezza di quell’umano sforzo ergentesi nella vastità del mondo. Spettacolo che l’anima gelosamente accoglieva e serbava. Non era la gran rivelazione: era il lavorìo sotterraneo dei germi che già sentono il calore del sole vicino e ne temono e ne desiderano il pieno splendore.”
Accade anche a lei di vivere, come i germi di cui parla, il “lavorìo sotterraneo” in cui man mano la coscienza si fa vigile, pronta a mollare ogni fardello. Impossibile contrastare un’anima traboccante di dolore e di amore come la sua, un’anima sempre in cerca. E se il senso della sua esistenza non lo troverà nelle braccia cristiane, come accade a tanti credenti, questo non le toglierà il gusto del mistero divino: “Volgono le epoche, tramontano i sogni e le certezze, si trasformano le nostre brame; ma immutato resta il potere d’amore e di dolore nella creatura terrena, immutata la facoltà di esaltarsi sino a intendere voci fraterne nello spazio in apparenza deserto”.
Queste voci fraterne non saranno per Sibilla quelle dei fratelli raccolti in una chiesa, ma le voci dei poveri, dei diseredati. Quelle figure che non riesce a fuggire sono le stesse che incontra quando abbandona le vie centrali di Roma e si imbatte nelle case sporche, piene di lamenti e di sofferenze, che perimetrano con la loro ombra sinistra il raggiante centro della città, con le sue piazze assolate e le case con le finestre ingombre di fiori.
A un certo punto capisce anche che è incontrando la sofferenza degli altri che riesce a domare anche la sua, e si sente trascinata verso quelle questioni civili, sociali, di cui ha sempre letto con interesse.
Il tema femminile rimarrà per lei sempre centrale, però. “Quasi inavvertitamente il mio pensiero s’era giorno per giorno indugiato un istante di più su questa parola: emancipazione che ricordavo d’aver sentito pronunciare nell’infanzia, una o due volte, da mio padre seriamente, e poi sempre con derisione da ogni classe d’uomini e di donne. Indi avevo paragonato a quelle ribelli la gran folla delle inconsapevoli, delle inerti, delle rassegnate, il tipo di donna plasmato nei secoli per la soggezione e di cui io, le mie sorelle, mia madre, tutte le creature femminili da me conosciute, eravamo degli esemplari. E come un religioso sgomento m’aveva invaso. Io avevo sentito di toccare la soglia della mia verità, sentito ch’ero per svelare a me stessa il segreto del mio lungo, tragico affanno…”
La sua verità, la chiama. Perché giustamente ognuno ha una sua verità, un qualcosa di estremamente personale da conoscere e ri-conoscere dentro di sé.
Questo qualcosa pulsa, si agita, matura nello spazio concesso da una solitudine cercata, voluta, interrotta per lei solo dalle ore passate con il figlio. Al ritorno dal periodo romano in cui Sibilla incontra la sua vocazione letteraria e sociale, continueranno le percosse, le intimidazioni, le minacce da parte del marito, reso ancora più violento dalla fierezza di lei, da quel fuoco che nessuno può spegnere. L’incendio stavolta divampa sul serio. C’è un olocausto però, e una vittima da sacrificare: il figlio. Ma non può, non vuole consegnargli ciò che lei stessa ha ricevuto da sua madre: l’infelicità, lo sdoppiamento di un’anima scissa tra il richiamo a sé stessa e il voto materno. E decide di andarsene.
È questo il prezzo aspro che deve pagare. Sono pagine terribili quelle che descrivono l’ultima veglia, le incertezze e i ripensamenti, lo smarrimento davanti al faccino addormentato di lui. Vorrebbe portarlo via, rapirlo, ma non può. La legge le è contro. All’alba si strappa via dal lettino su cui dorme il bambino e se ne va, con le schegge del cuore ormai esploso che le schizzano via. Nella speranza di non perderlo, però. Nell’attesa che il bambino cresca, e capisca. In fondo è lui il cibo delle sue parole. “O forse io non sarò più… Non potrò più raccontargli la mia vita, la storia della mia anima…e dirgli che l’ho atteso per tanto tempo! Ed è per questo che scrissi. Le mie parole lo raggiungeranno”. L’ultima, tenace speranza.
|